L’Italia è quel Paese dove 140 morti e anche il loro ricordo scompaiono dietro a un banco di nebbia che non c’era. Il 10 Aprile dovrebbe sempre essere sempre una pessima giornata, per non si accontenta di sentenze dalla grafia incerta. Quel giorno, nel 1991, il traghetto Moby Prince appena salpato dal porto di Livorno urtò con la prua una petroliera, l’Agip Abruzzo. Morirono tutti i passeggeri, radunati nel salone centrale della nave, e i membri dell’equipaggio. Centoquaranta persone. Un solo superstite. Nessuna verità, plausibile o meno.
«L’ultimo decreto di archiviazione non ha alcun riscontro nelle carte usate per scriverlo, che anzi affermano l’esatto contrario di quel che sostiene il giudice. Noi ci abbiamo messo nuove tecnologie, ma i documenti sono gli stessi. Siamo ancora qui, a chiedere un’ultima possibilità di avere finalmente giustizia». Milano, uno studio tecnico a due passi dal tribunale. Luci accese alla fine di un lento pomeriggio trascorso nella penombra, a esaminare filmati, elaborazioni al computer. Angelo Chessa, chirurgo specializzato in ortopedia. È il figlio di Ugo, comandante della Moby Prince, di lunga e onorata carriera. Nel 1991 aveva 25 anni. Stava finendo l’università a Milano. Vide le immagini al tg del mattino. Capì subito. Ancora non sapeva che a bordo c’era anche sua madre, Maria Giulia, salita all’ultimo momento. La trovarono tra i corpi ammassati nel salone.
«Tutto chiaro»? L‘ingegner Gabriele Bardazza, il padrone di casa, consapevole dei rischi di questa intensa sessione tra reperti e diagrammi, interrompe il racconto di Chessa. I principali clienti del suo studio di ingegneria sono i magistrati di Milano, per i quali ha ricostruito la dinamica della strage di Linate. Dal 2010, per la prima volta, ha accettato di lavorare per una parte civile. Amicizia, al netto del rimborso spese. «Una condotta gravemente colposa, in termini di imprudenza e negligenza, della plancia del Moby Prince». L’ultima archiviazione è arrivata nel 2010. Con queste parole. La morte estingue ogni reato, ma quella colpa ricade sul padre di Chessa. «Le indagini andarono in una sola direzione, la più facile. Troppi interessi da coprire, tra Agip e porto. Tutti ormai riconoscono che si tratta di una specie di Ustica dei mari, nessuno ne parla. Non è più una questione privata. Io mi ribello a un oblio ingiusto».
Sono passati 22 anni. Quel che doveva essere è stato, forse. I reati sono prescritti, visto che mai si è proceduto per strage. Dei nostri tanti misteri, quello della Moby Prince è davvero il più misconosciuto. La presenza di navi militari americane in rada, l’ipotesi concreta di una esplosione a bordo del traghetto precedente il disastro, le responsabilità di soccorsi tardivi e maldestri: tutto è sempre rimasto sotto il coperchio di sentenze minimaliste. I fatti non sussistevano e comunque erano difficili da vedere, coperti com’erano da una inopinata «nebbia d’avvezione» che ha incardinato il primo processo eliminando ogni ricostruzione alternativa a quella dell’errore umano. Un fenomeno improvviso, molto diffuso ma ai Tropici, che dal nulla aveva creato una barriera di 300 metri, a misura di petroliera.
Il nuovo lavoro di indagine parte da qui. Da vecchie incongruenze e da nuovi strumenti di lavoro. La prova regina della scarsa attenzione dell’equipaggio è per i giudici «clamorosamente esplicitata» dal portellone prodiero aperto, nonostante la normativa Marpol 73-78 lo proibisse. All’epoca nessuno fece caso a questo passaggio. Ma la legge che vieta di navigare in tali condizioni sarebbe entrata in vigore solo nel 1992, e riguardava le nuove imbarcazioni. La Moby Prince avrebbe dovuto adeguarsi nel 1995. Marpol 73-78 invece altro non sarebbe che un testo non vincolante sulla polluzione marina, dove non si fa alcun cenno alla sicurezza.
Il punto più delicato è quello della posizione della petroliera Agip Abruzzo, ufficialmente collocata fuori dal triangolo d’acqua all’uscita del porto, dov’era vietato l’ancoraggio. Un video girato pochi minuti dopo l’impatto, e una ricerca fatta a Livorno per identificare nell’oscurità i cosidetti «punti cospicui» sulla terraferma, sembra invece stabilire come la petroliera fosse ben dentro l’area proibita. Un’altra scoperta, d’archivio: già nelle motivazioni della sentenza di primo grado le coordinate collocano la Agip Abruzzo là dove non doveva essere. Era una notizia di reato. Nessuno la vide.
Come la nebbia, che continua a persistere nonostante decine di filmati che mostrano una notte limpida. In uno di questi si vedono i bagliori delle fiamme della Moby Prince dietro e non davanti alla sagoma della petroliera. Se confermata, sarebbe una novità, non da poco, che ribalterebbe la dinamica della collisione: la Moby Prince non stava uscendo, ma rientrando in porto. Le ragioni di questa presunta inversione di rotta non le sapremo mai, come molto altro di questa storia. La nuova indagine vuole fugare inoltre ogni dubbio sul numero di navi americane presenti in rada. Una sola, ma molto vicina alla petroliera al momento dell’urto con la Moby Prince, come sembra dimostrare il notevole lavoro sulle comunicazioni radio, dal quale si evince che a parlare in inglese è sempre la stessa voce.
A parità di gomitolo, l’obiettivo dichiarato di questa monumentale contro inchiesta durata tre anni è di mostrare un filo rosso diverso da quello individuato dai magistrati, per ottenere un nuovo processo, penale o civile non importa. «A me interessa stabilire una verità storica. Quella tragedia non ha generato nulla, non ha insegnato niente. Centoquaranta morti inutili. Nel nome di una verità di comodo». Il figlio del comandante Ugo mostra due ritagli di giornale ingialliti. La Nazione , 15 e 16 aprile, pochi giorni dopo il disastro. Quel momento raro dove si raccolgono le notizie sul campo, prima che indagini e verità ufficiali prendano possesso del terreno. Il primo titolo è «La petroliera non doveva essere lì». Il secondo fa riferimento al notevole traffico di navi militari registrato quella notte al porto. Sono gli unici articoli che mancano dalla rassegna stampa allegata agli atti.
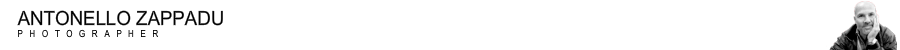



 invio in corso...
invio in corso...
Commenti recenti